Shop
Visualizzazione di 41-48 di 180 risultati
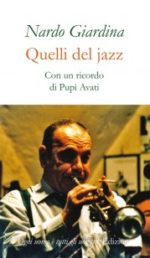
Nardo Giardina
Quelli del jazz
Finalmente il 16 aprile 1952 proprio al “Modernissimo”, in una serata di jazz che aveva come “stella” Gianni Basso, allora virtuoso del sax-tenore, debuttammo con il nome di “Magistratus Jazz Band” facendo sì che, dopo Roma e Milano, anche Bologna avesse la sua “Jazz Band”.
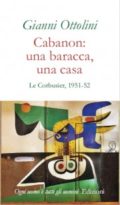
Gianni Ottolini
Cabanon: una baracca, una casa
Disegnato a fine dicembre 1951 come regalo alla moglie Yvonne per il suo compleanno e costruito nel 1952 “su un tratto di roccia battuto dai flutti” dopo uno sviluppo progettuale veloce e sicuro “grazie al Modulor”, il Cabanon (piccola capanna o anche villino, in Provenza) ha una configurazione che non sembra nata immediatamente così com’è, ma come sola parte notturna di un intero alloggio rialzato dal terreno, con scala di accesso, bagno di servizio, cucina, pranzo e soggiorno rivolto verso il mare, forse una cellula dei complessi insediativi Roq e Rob in una delle loro versioni (nella prima, del 1949, Le Corbusier aveva anche brevettato un modulo costruttivo cubico a pilastri e travi in lamiera piegata di alluminio di 226x226x226 cm, con copertura a volta), con cui intendeva dare una “vera ragione” paesaggistica all’architettura della Costa Azzurra deturpata da una polluzione
di casette di ogni stile.
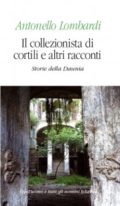
Antonello Lombardi
Il collezionista di cortili e altri racconti
La cerimonia di pensionamento era stata breve e piuttosto malinconica.
Dopo aver insegnato per trent’anni Storia e Geografia nelle scuole medie, Memo Perisi lasciava l’insegnamento.
A salutarlo con un bicchiere di Cinzano e i pasticcini secchi c’erano solo il preside, il collega di educazione fisica e la segretaria dell’Istituto, Carla.
Gli altri docenti avevano accampato scuse varie, più o meno credibili.
La verità è che Memo era simpatico a pochi e di ciò, perfettamente consapevole, non si era mai minimamente curato.
Solitario, taciturno, molto timido da sembrare, a volte, irrispettoso.
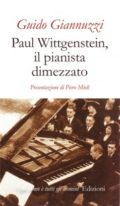
Guido Giannuzzi
Paul Wittgenstein, il pianista dimezzato
Il primo dicembre del 1913, Paul Wittgenstein, figlio di una delle più importanti famiglie viennesi, ha già ventisei anni, studia pianoforte con determinazione e affronta il suo primo concerto pubblico. Lo scoppio della Prima guerra mondiale, nel luglio del 1914, gli impedirà di tenerne altri, perché costretto ad arruolarsi nell’esercito imperiale.
...
Dopo il rimpatrio, nel dicembre del ’16, Paul diede il primo concerto, davanti a un pubblico impressionato, ipnotizzato da quella manica destra vuota come dalla inaspettata abilità della mano sinistra.
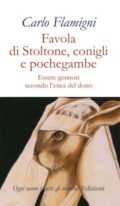
Carlo Flamigni
Favola di Stoltone, conigli e pochegambe.
Cosa sapete dei conigli? Poco? Lasciate allora che vi racconti una storia che li riguarda (e che tutti i conigli conoscono).
Molti, molti anni prima Eureka, l’isola dei conigli, per molti versi bellissima, non poteva essere abitata dagli esseri umani per via dei continui terremoti che la affliggevano: tutto dipendeva dal fatto che sotto la crosta superficiale l’isola era una specie di gruviera, tutta forata da grotte immense, una delle quali di tanto in tanto crollava causando grandi disastri.
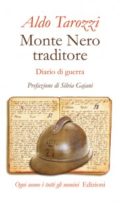
Aldo Tarozzi
Monte Nero traditore
AldoTarozzi è nato a Castelfranco Emilia il 23 maggio del 1898. Ha frequentato ginnasio e liceo nel Collegio dei Salesiani di Bologna fino alla chiamata alle armi nel marzo del 1917. È stato al fronte come artigliere ed eliografista fino al gennaio 1920 quando è stato congedato.
Trasferito a Genova dopo la guerra (1921), ha esercitato inizialmente vari lavori, per poi essere assunto come impiegato nelle Ferrovie (prima a Genova, poi a Bologna). Sposatosi a Castelfranco Emilia, nel 1926, con Giuseppina Piccioli, ha avuto tre figli. È morto il 1° giugno del 1972.
Ha ricevuto la Croce di guerra come combattente della Prima guerra mondiale e gli sono state conferite, postume, medaglia e nomina a Cavaliere di Vittorio Veneto.
La sua passione è stata la pittura, a cui si è dedicato per tutta la vita, ottenendo autorevoli riconoscimenti e realizzando mostre in diverse città: Modena, Bologna, Castelfranco Emilia e Seveso al Palazzo delle Esposizioni. Retrospettive postume hanno avuto luogo a Casalecchio di Reno, a Castelfranco Emilia, e a Bologna in tre successive mostre, di cui la seconda, nel ’93, alla Villa Aldrovandi Mazzacorati, promossa dalla Commissione comunale cultura e l’ultima, col patrocinio della Banca Popolare di Milano, nell’anno 2002.
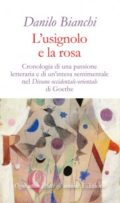
Danilo Bianchi
L’usignolo e la rosa
Nel suo insieme il Divano occidentale-orientale è naturalmente molto di più di una raccolta di sole poesie amorose. Attraverso la complessità dei registri linguistici, la varietà dei toni, che possono passare dall’ironico al sentenzioso, e la presenza di alcuni argomenti legati alla storia o alla politica, Goethe riesce ad entrare empaticamente in sintonia con lo spirito del Canzoniere di Hâfez.
[...]
Dovettero trascorrere quasi esattamente cento anni dal viaggio letterario di Goethe in Oriente e dalla pubblicazione del suo Divan, prima che la “natura morta poetica” del motivo dell’usignolo e della rosa si materializzasse in una moderna immagine pittorica.

Giacomo Leopardi
Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco
Prefazione di Giuliano Toraldo di Francia -
Con manoscritto -
Giacomo Leopardi, come si sa, rappresenta una luminosa eccezione nel panorama culturale non solo della sua epoca, per quanto riguarda l’interesse alle cose della scienza. In generale i letterati, i poeti, i filologi italiani dell’Ottocento (o dovremmo dire anche del nostro secolo?) non brillano per la loro informazione e comprensione per i problemi scientifici. Molto spesso li lasciano semplicemente fuori dal loro concetto di “cultura”...
Non così il Leopardi, che quando alza gli occhi al cielo e si domanda “a che tante facelle?” lo fa da sommo poeta, sì, ma anche da studioso che segue con attenta curiosità i progressi che gli specialisti vanno facendo nella comprensione del mondo naturale.